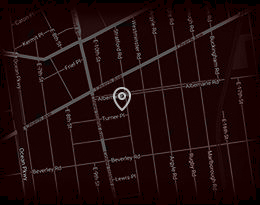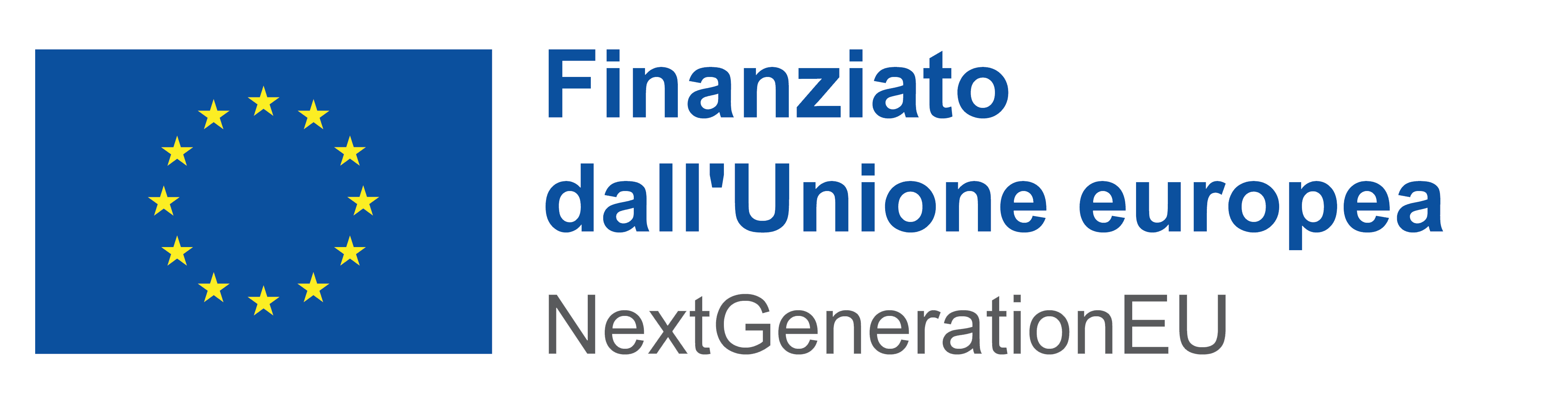Il concerto verrà registrato domenica 21 marzo 2021 e, in seguito, trasmesso in streaming
Manfred Honeck
Programma
Franz Joseph Haydn
Sinfonia in re maggiore Hob. I:93
Anton Bruckner
Locus iste, graduale in do maggiore per coro
Lili Boulanger
Pie Jesu per soprano, organo, arpa e archi
Gabriel Fauré
Cantique de Jean Racine op. 11 per coro, arpa e archi
Wolfgang Amadeus Mozart
Laudate Dominum da Vesperae Solennes de Confessore K. 339 per soprano, coro, fagotto, organo e archi
Ave verum corpus, mottetto in re maggiore K. 618 per coro, organo e archi
Sinfonia in mi bemolle maggiore K. 543
-
Franz Joseph Haydn - Sinfonia n. 93 in re maggiore
Nel 1790 Haydn fu invitato a comporre un ciclo di sinfonie per i teatri di Londra. L’offerta allettante, sia in termini economici che di prestigio, era giunta da Johann Peter Salomon, impresario teatrale e direttore di un’orchestra da lui fondata nella capitale britannica. Haydn accettò e giunto in Inghilterra si mise immediatamente a lavoro. Tra il 1791 e il 1792 nacque il primo dei due cicli di sinfonie - dodici in tutto - denominate ‘londinesi’. La Sinfonia n. 93 in re maggiore, la prima del ciclo, fu tenuta a battesimo da Salomon, che a capo della sua orchestra la diresse il 17 febbraio del 1792 riscuotendo enorme successo. Come le altre sorelle del gruppo, la Sinfonia n. 93 si apre con un Adagio dal tono solenne che introduce l’Allegro, dove risalta il primo tema in ritmo di valzer. Nei movimenti centrali - Largo cantabile e Minuetto - Haydn gioca e si diverte con contrasti dinamici e soluzioni timbriche ricche di humor; mentre il quarto movimento, tutto verve ed energia, chiude l’opera nel segno della festosità.
Anton Bruckner - Locus iste
Il breve mottetto per coro di voci miste Locus iste - su testo dell’omonimo graduale latino - fu composto da Anton Bruckner nel 1869 per la consacrazione della cappella votiva della cattedrale di Linz. Del resto, la carriera di Bruckner era iniziata proprio tra il silenzio delle navate delle cattedrali austriache (compresa quella di Linz) dove si era fatto le ossa come organista sperimentando in lungo e in largo le varie forme di musica sacra. Non stupisce quindi che nel suo catalogo spicchino per quantità le composizioni religiose e che la produzione mottetistica, in particolar modo, occupi un posto di rilievo avendo accompagnato Bruckner dai primi anni di carriera fino alla grande esperienza sinfonica. A differenza di altre sue opere sacre marcatamente arcaizzanti, il Locus iste si distingue per la melodia semplice e lineare e per l’andamento prevalentemente omoritmico.
Lili Boulanger - Pie Jesu per soprano, organo, arpa e archi
Prima donna compositrice a vincere il prestigioso ‘Prix de Rome’ nel 1913, Lili Boulanger pare destinata a una carriera di successo se non fosse per una malattia invalidante giunta troppo presto a sbarrarle la strada e a condurla alla morte a soli ventiquattro anni. Proprio negli ultimi anni di vita, tuttavia, Lili compone alcune tra le sue opere più riuscite. Nel marzo del 1918 la compositrice stremata dalla malattia non ha più le forze per scrivere musica, ma ciononostante riesce a dettare, nota dopo nota, la cantata Pie Jesu alla sorella Nadia, anch’essa compositrice e nota didatta. Il Pie Jesu è una sorta di testamento musicale in cui l’invocazione universale alla pace eterna rivolta al figlio di Dio misericordioso assume un valore assolutamente autobiografico. Un lungo ostinato di organo e archi accompagna una melodia vocale dolente e angosciata dall’incedere affannoso. Solo alla fine uno sprazzo di luce consolatorio si fa strada con il suono etereo dell’arpa: è la promessa della pace tanto attesa in un mondo che non è più terreno.
Gabriel Fauré - Cantique de Jean Racine op. 11
Nel 1865 il Cantique de Jean Racine op. 11 valse al giovane Gabriel Fauré il primo premio al concorso indetto dall’École Niedermeyer di Parigi, la più importante istituzione di musica sacra di cui Fauré era stato tra i migliori allievi. Il testo tratto dalla traduzione di Jean Racine dell’inno latino Consors paterni, attribuito a S. Ambrogio, è declinato in una scrittura limpida ed elegante, una caratteristica dello stile di Fauré già riscontrabile in questa pagina giovanile. Il brano, scritto originariamente per coro di voci miste e organo, sarà eseguito in una versione per coro, arpa e archi di Manfred Honeck.
Wolfgang Amadeus Mozart - Laudate Dominum da Vesperae Solennes de Confessore K. 339
Negli anni trascorsi a servizio dell’arcivescovo di Salisburgo Mozart aveva prodotto numerose composizioni di musica sacra destinate a celebrare le solennità del calendario liturgico. I Vespri K. 339 - ultima opera della produzione sacra salisburghese - furono composti nel 1780 in occasione di una cerimonia in onore di un santo confessore della Chiesa non meglio identificato. Nei Vespri - composti da cinque Salmi della Vulgata (Dixit Dominus, Confitebor, Beatus Vir, Laudate Pueri, Laudate Dominum) più il Magnificat finale - convivono armoniosamente pagine scritte in contrappunto severo e pagine edonistiche di evidente impronta teatrale. A quest’ultimo gruppo appartiene il Laudate Dominum, aria per soprano, coro e orchestra dove la melodia della solista che si libra in volo su un sommesso accompagnamento orchestrale è pura poesia, è l’incanto del suono che fa dimenticare qualsiasi appartenenza di genere o classificazione.
Wolfgang Amadeus Mozart - Ave verum corpus K. 618
Il breve mottetto per coro, archi e organo Ave verum corpus K. 618 è tra i brani più conosciuti e amati della produzione sacra mozartiana. Nell’estate del 1791 Mozart aveva raggiunto la moglie in villeggiatura a Baden e per sdebitarsi con l’amico Anton Stoll, direttore del coro locale, compose questa pagina che venne eseguita durante le celebrazioni della festa del Corpus Domini. Nell’Ave verum Mozart adotta una scrittura omofonica per meglio sottolineare il significato del testo, realizzando pur nella brevità - solo quarantasei battute - e con pochi mezzi strumentali - l’organico è ridotto ai soli archi e organo vista la destinazione per la chiesa di paese - un gioiello di immediatezza espressiva.
Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K. 543
Prima delle tre ultime sinfonie mozartiane, la Sinfonia in mi bemolle maggiore K. 543 fu composta nel giugno del 1788. Per Mozart quell’anno fu davvero difficile sul versante personale - tra le preoccupazioni dovute a una situazione economica disastrosa e la delusione subita per il mancato successo viennese del Don Giovanni - ma altresì fruttuoso sul versante della creatività. In quell’estate, sotto la spinta bruciante del suo talento, Mozart diede alla luce i tre capolavori sinfonici che chiudono la sua produzione nel genere e rappresentano la summa della sua arte orchestrale. Nella Sinfonia K. 543 per la prima volta Mozart impiega al posto degli oboi i clarinetti, strumenti che all’epoca non avevano ancora una sistemazione stabile in orchestra ma erano particolarmente amati dal compositore per il timbro morbido e pastoso. Seguendo il venerabile modello di Haydn, la Sinfonia K. 543 si apre con un imponente Adagio introduttivo: vigorosi accordi seguiti da scalette ascendenti e discendenti cariche di tensione aprono la strada al primo tema dell’Allegro, che da principio entra quasi in punta di piedi per prendere poi forza sostenuto da trombe e timpani. L’Andante è costruito su un tema di serena cantabilità, ma inaspettatamente assume al centro colori cupi e drammatici. Segue un Minuetto dal passo imperioso che cede spazio nel Trio all’aggraziato dialogo tra il flauto e la coppia di clarinetti. La chiusura, invece, è scintillante con lo slancio inarrestabile del tema dell’Allegro finale che rimbalza senza sosta tra le varie famiglie orchestrali.
Artisti
Direttore
Manfred Honeck
Soprano
Francesca Aspromonte
Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro del Coro
Lorenzo Fratini
Manfred Honeck
Soprano
Francesca Aspromonte
Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro del Coro
Lorenzo Fratini
Durata
Durata complessiva: 1 ora e 40 minuti circa
Recite
Teatro del Maggio - Streaming
Locandina