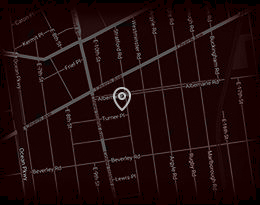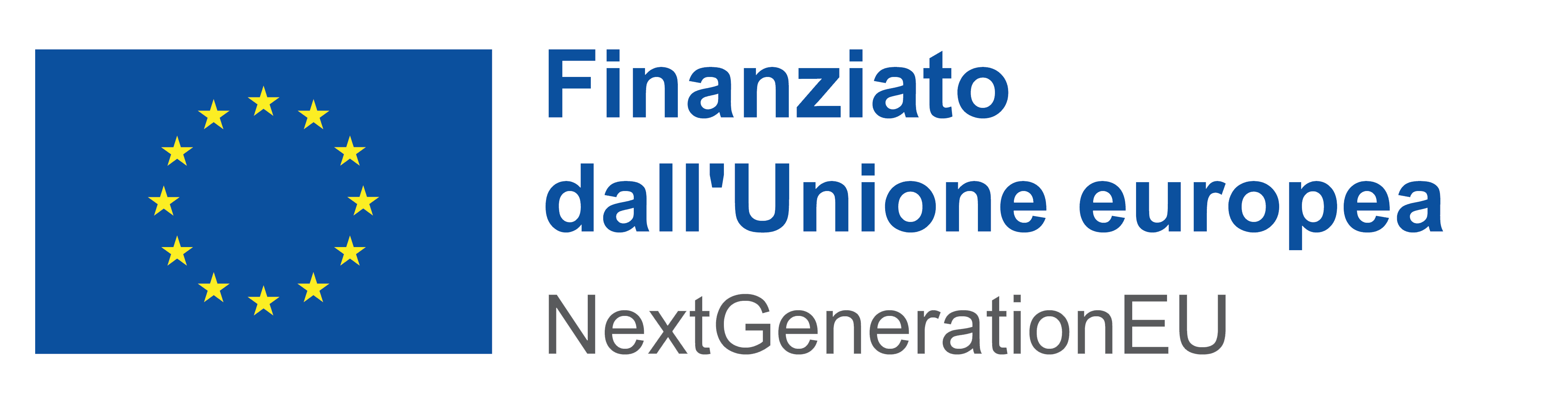Riccardo Muti/Wiener Philharmoniker
Programma
Si prega di prendere visione dell'informativa COVID-19 nella gestione dei posti
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27, Ouverture in re maggiore
Robert Schumann
Sinfonia n. 4 in re minore op. 120
Johannes Brahms
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73
Per restare aggiornati sulle attività del maestro Riccardo Muti vi invitiamo a visitare il sito internet ufficiale www.riccardomutimusic.com
Partner esclusivo della Filarmonica di Vienna

Foto del maestro Riccardo Muti: © Todd Rosenberg Photography - by courtesy of RMMUSIC
Foto dei Wiener Philharmoniker: © Lois Lammerhuber
-
Felix Mendelssohn-Bartholdy - Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27, ouverture in re maggiore
L’ouverture Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27 risale al 1828 ed è ispirata ai poemi di Goethe Calma di mare e Viaggio felice, messi in musica anche da Beethoven. Il contenuto poetico si riflette nella struttura dell’ouverture che Mendelssohn suddivide in sezioni: l’Adagio introduttivo che evoca l’immobilità del mare in un giorno di bonaccia e il Molto Allegro che descrive la navigazione tra le onde fluttuanti e il gioioso approdo finale; il tutto associato a una scrittura scorrevole e a una strumentazione cristallina.
Robert Schumann - Sinfonia n. 4 in re minore op. 120
Anche se catalogata a posteriori come Quarta, la Sinfonia in re minore è in ordine cronologico la seconda delle sinfonie di Robert Schumann. Fu composta nel 1841 in un periodo di estrema creatività; nell’arco di pochi mesi videro infatti la luce alcune importanti pagine della produzione schumanniana tra cui la Prima Sinfonia op. 38 e, appunto, la Sinfonia in re minore. Tuttavia lo scarso successo ottenuto alla prima esecuzione a Lipsia (il 6 dicembre di quello stesso anno) distolse l’autore dall’intento di pubblicare la partitura, che venne accantonata e revisionata dieci anni più tardi. Nella rinnovata e definitiva veste la Sinfonia in re minore sarà riproposta al pubblico il 3 marzo del 1853 a Düsseldorf per poi essere pubblicata con il numero d’opera 120. La revisione interessò soprattutto la strumentazione, che Schumann rinforzò, mentre l’impianto rapsodico rimase invariato. Fin dal principio l’autore aveva pensato a una sinfonia in quattro movimenti senza soluzione di continuità collegati tra loro da una fitta rete di rimandi armonici e melodici, ossia a una forma che per struttura e concezione era assimilabile alla fantasia sinfonica piuttosto che alla sinfonia classica. Sono le analogie tematiche tra lo slancio inquieto e appassionato del primo movimento, la struggente malinconia della Romanza, le divagazioni fantastiche del Trio, fino all’allegra baldanza del Finale a conferire unità e coesione all’opera. L’intero processo sinfonico prende infatti vita dal breve inciso presentato nell’Introduzione che reca già in luce gli elementi funzionali alla costruzione dei temi principali della sinfonia, i quali germineranno l’uno dall’altro senza contrapposizioni ma secondo un procedimento ciclico.
Johannes Brahms - Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73
Era trascorso appena un anno dalla presentazione della Prima Sinfonia quando nell’estate del 1877, sulle sponde del lago di Wörth in Carinzia, vide la luce la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73. La rapidità con cui Brahms attese alla nuova composizione fu sorprendente se paragonata alla lunghissima gestazione, durata quasi un ventennio, che accompagnò la sua prima creatura sinfonica. Se la Prima era stata salutata come ‘decima sinfonia’, alludendo all’eredità beethoveniana di cui Brahms si fa custode e garante, la Seconda fu denominata ‘pastorale’ per il suo carattere prevalentemente lirico e melodico, ma anche ‘viennese’ per l’impiego del ritmo di valzer in due dei quattro movimenti. È un motto di sole tre note, intonato dagli archi gravi a cui rispondono corni, fagotti, flauti e clarinetti, a dare l’attacco all’opera. Potrebbe sembrare un’introduzione ma in realtà è già il tassello fondamentale con cui Brahms, attraverso l’uso sapiente della tecnica di variazione-sviluppo, costruisce il primo tema e da lì l’intero discorso sinfonico. L’Adagio seguente è una pagina di intenso lirismo che accoglie le sonorità cameristiche di fiati e archi al ritmo cullante di berceuse, mentre l’Allegretto grazioso con i suoi due Trii si muove spensierato a passo di danza bucolica. Nell’ultimo movimento, a sancire il collegamento con l’inizio della sinfonia, ecco ricomparire il motto iniziale di tre note che Brahms trasforma con innumerevoli combinazioni ritmico-melodiche nel tripudio generale dell’orchestra.
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27, Ouverture in re maggiore
Robert Schumann
Sinfonia n. 4 in re minore op. 120
Johannes Brahms
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73
Per restare aggiornati sulle attività del maestro Riccardo Muti vi invitiamo a visitare il sito internet ufficiale www.riccardomutimusic.com
Partner esclusivo della Filarmonica di Vienna

Foto del maestro Riccardo Muti: © Todd Rosenberg Photography - by courtesy of RMMUSIC
Foto dei Wiener Philharmoniker: © Lois Lammerhuber
-
Felix Mendelssohn-Bartholdy - Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27, ouverture in re maggiore
L’ouverture Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27 risale al 1828 ed è ispirata ai poemi di Goethe Calma di mare e Viaggio felice, messi in musica anche da Beethoven. Il contenuto poetico si riflette nella struttura dell’ouverture che Mendelssohn suddivide in sezioni: l’Adagio introduttivo che evoca l’immobilità del mare in un giorno di bonaccia e il Molto Allegro che descrive la navigazione tra le onde fluttuanti e il gioioso approdo finale; il tutto associato a una scrittura scorrevole e a una strumentazione cristallina.
Robert Schumann - Sinfonia n. 4 in re minore op. 120
Anche se catalogata a posteriori come Quarta, la Sinfonia in re minore è in ordine cronologico la seconda delle sinfonie di Robert Schumann. Fu composta nel 1841 in un periodo di estrema creatività; nell’arco di pochi mesi videro infatti la luce alcune importanti pagine della produzione schumanniana tra cui la Prima Sinfonia op. 38 e, appunto, la Sinfonia in re minore. Tuttavia lo scarso successo ottenuto alla prima esecuzione a Lipsia (il 6 dicembre di quello stesso anno) distolse l’autore dall’intento di pubblicare la partitura, che venne accantonata e revisionata dieci anni più tardi. Nella rinnovata e definitiva veste la Sinfonia in re minore sarà riproposta al pubblico il 3 marzo del 1853 a Düsseldorf per poi essere pubblicata con il numero d’opera 120. La revisione interessò soprattutto la strumentazione, che Schumann rinforzò, mentre l’impianto rapsodico rimase invariato. Fin dal principio l’autore aveva pensato a una sinfonia in quattro movimenti senza soluzione di continuità collegati tra loro da una fitta rete di rimandi armonici e melodici, ossia a una forma che per struttura e concezione era assimilabile alla fantasia sinfonica piuttosto che alla sinfonia classica. Sono le analogie tematiche tra lo slancio inquieto e appassionato del primo movimento, la struggente malinconia della Romanza, le divagazioni fantastiche del Trio, fino all’allegra baldanza del Finale a conferire unità e coesione all’opera. L’intero processo sinfonico prende infatti vita dal breve inciso presentato nell’Introduzione che reca già in luce gli elementi funzionali alla costruzione dei temi principali della sinfonia, i quali germineranno l’uno dall’altro senza contrapposizioni ma secondo un procedimento ciclico.
Johannes Brahms - Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73
Era trascorso appena un anno dalla presentazione della Prima Sinfonia quando nell’estate del 1877, sulle sponde del lago di Wörth in Carinzia, vide la luce la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73. La rapidità con cui Brahms attese alla nuova composizione fu sorprendente se paragonata alla lunghissima gestazione, durata quasi un ventennio, che accompagnò la sua prima creatura sinfonica. Se la Prima era stata salutata come ‘decima sinfonia’, alludendo all’eredità beethoveniana di cui Brahms si fa custode e garante, la Seconda fu denominata ‘pastorale’ per il suo carattere prevalentemente lirico e melodico, ma anche ‘viennese’ per l’impiego del ritmo di valzer in due dei quattro movimenti. È un motto di sole tre note, intonato dagli archi gravi a cui rispondono corni, fagotti, flauti e clarinetti, a dare l’attacco all’opera. Potrebbe sembrare un’introduzione ma in realtà è già il tassello fondamentale con cui Brahms, attraverso l’uso sapiente della tecnica di variazione-sviluppo, costruisce il primo tema e da lì l’intero discorso sinfonico. L’Adagio seguente è una pagina di intenso lirismo che accoglie le sonorità cameristiche di fiati e archi al ritmo cullante di berceuse, mentre l’Allegretto grazioso con i suoi due Trii si muove spensierato a passo di danza bucolica. Nell’ultimo movimento, a sancire il collegamento con l’inizio della sinfonia, ecco ricomparire il motto iniziale di tre note che Brahms trasforma con innumerevoli combinazioni ritmico-melodiche nel tripudio generale dell’orchestra.
Artisti
Direttore
Riccardo Muti
Wiener Philharmoniker
Riccardo Muti
Wiener Philharmoniker
Biglietti
Teatro del Maggio
Loading map...
Locandina