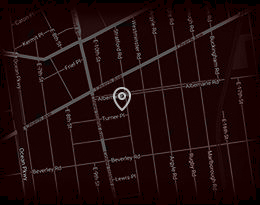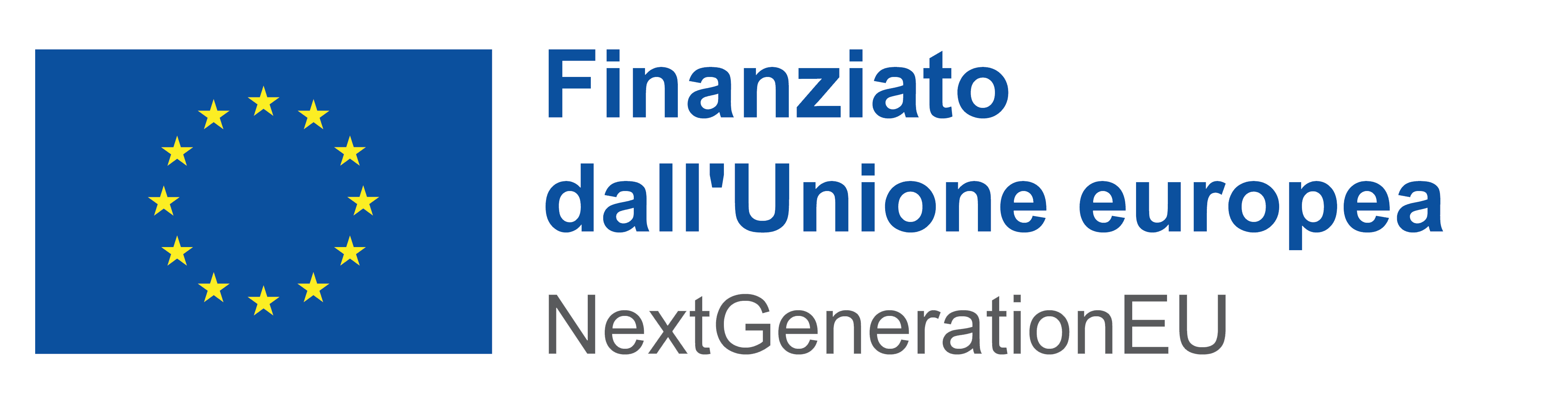Il concerto verrà registrato domenica 11 aprile 2021 e, successivamente, trasmesso in streaming
Zubin Mehta/Vilde Frang
Programma
Ludwig van Beethoven
Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90, Italiana
Ottorino Respighi
Pini di Roma, poema sinfonico
-
Ludwig van Beethoven - Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61
Nel corso della sua carriera Beethoven si dedicò assai di rado alle composizioni per violino e orchestra; così, a parte le due Romanze op. 40 e op. 50, il Concerto in re maggiore op. 61 rappresenta non solo la sua opera somma nel genere ma anche l’unico concerto scritto per questo strumento. L’occasione fu fornita dalla conoscenza del violinista Franz Clement, noto virtuoso del tempo, direttore del Theater an der Wien, nonché dedicatario e primo interprete dell’opera. La partitura, iniziata nell’autunno del 1806, fu pronta in poche settimane e il 23 dicembre di quello stesso anno il Concerto op. 61 debuttò con Clement solista al Theater an der Wien, suscitando pareri discordanti. L’iniziale diffidenza nei confronti di quest’opera - che nei decenni seguenti troverà la sua meritata affermazione - fu dettata dalla sua natura poco virtuosistica. A differenza di altri concerti per violino e orchestra, dove il solista fa bella mostra delle proprie capacità con virtuosismi di ogni sorta sulle quattro corde, il Concerto op. 61 di Beethoven è invece improntato a una scrittura elegante e cantabile che poco concede al virtuosismo puro. Anche il rapporto dialettico tra solista e orchestra risente di questa scelta poiché risulta privo di forti contrapposizioni timbriche e dinamiche e non si risolve, come ci si aspetterebbe, con il prevalere esclusivo del solista sull’orchestra ma con un dialogo complice tra le due parti.
Felix Mendelssohn-Bartholdy - Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90, Italiana
Come ogni rampollo di buona famiglia del Nord Europa, anche Felix Mendelssohn coronò la fine dei suoi studi con un grand tour, il viaggio di formazione che aveva come tappa finale l’Italia. A Roma e a Napoli, dove soggiornò dal 1830 al 1831, Mendelssohn raccolse idee e spunti musicali che riverserà negli abbozzi della Sinfonia in la maggiore op. 90, portata a termine nel 1833 e battezzata, non a caso, “Italiana”. «È il lavoro più gaio che io abbia mai composto, specialmente nel finale», scriveva Mendelssohn con entusiasmo pensando a quella sinfonia nata nel Bel Paese, il cui ascolto delle prime battute basta da solo a confermare quanto detto dall’autore. L’Allegro vivace si apre con un tema risoluto e pieno di slancio che a passo danzante introduce l’ascoltatore nell’atmosfera festosa che domina il primo movimento. Il secondo movimento - Andante con moto - ha i toni della canzone nostalgica, mentre il terzo - Con moto moderato - per eleganza e soavità ricorda le movenze galanti del minuetto, interrotto nel Trio dai richiami campestri di corni e legni. Il movimento finale - Saltarello - è decisamente il più caratteristico della Sinfonia in la maggiore. Mendelssohn sceglie l’indiavolata danza popolare tipica dell’Italia centrale per innescare un discorso musicale vivacissimo in un clima incandescente che rende omaggio all’immagine dell’Italia baciata dal sole tanto cara alla sensibilità romantica.
Ottorino Respighi - Pini di Roma
Dopo il successo delle Fontane di Roma (1916), Ottorino Respighi tornò al poema sinfonico nel 1924 con Pini di Roma, quattro pannelli orchestrali ispirati ad alcuni luoghi simbolo della Città eterna. L’immagine dei giochi chiassosi dei bambini nei giardini di Villa Borghese apre il primo pannello, I pini di villa Borghese: ecco rincorrersi e intrecciarsi in orchestra canzoni popolari infantili, marcette, trilli degli archi e fanfare di trombe in una girandola di incontenibile allegria. La grande lezione di Rimskij-Korsakov, di cui Respighi era stato allievo, traspare non solo nei colori smaglianti e nella scrittura brillante riscontrabili in questa pagina, ma anche nella scelta di impasti timbrici mai scontati e innovativi come nei pannelli seguenti. Nel secondo quadro l’autore restituisce l’immagine delle catacombe romane (I pini presso una catacomba), con il suono di un’antica salmodia dai toni cupi e misteriosi affidata agli archi gravi e ai corni, mentre nel terzo quadro, che descrive l’incanto di una notte di luna, (I pini del Gianicolo) sfrutta le possibilità timbriche di strumenti quali l’arpa, il pianoforte, la celesta, i legni e gli archi per costruire delicatissime filigrane di gusto impressionista, interrotte solo alla fine dal canto registrato di un usignolo che segnala il passaggio dalla notte all’alba. Il quarto e ultimo pannello, I pini della via Appia, è un salto indietro nella storia dell’impero romano. Si odono in lontananza avanzare a passo deciso e marziale i legionari dell’antica Roma. L’effetto spaziale del passaggio di un esercito in movimento è costruito da Respighi con maestria grazie al crescendo orchestrale graduale e ben calibrato, dove si inseriscono via via sempre più strumenti.
Artisti
Direttore
Zubin Mehta
Violino
Vilde Frang
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Zubin Mehta
Violino
Vilde Frang
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Durata
Durata complessiva: 1 ora e 40 minuti circa
Recite
Teatro del Maggio - Streaming
Locandina