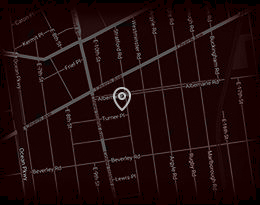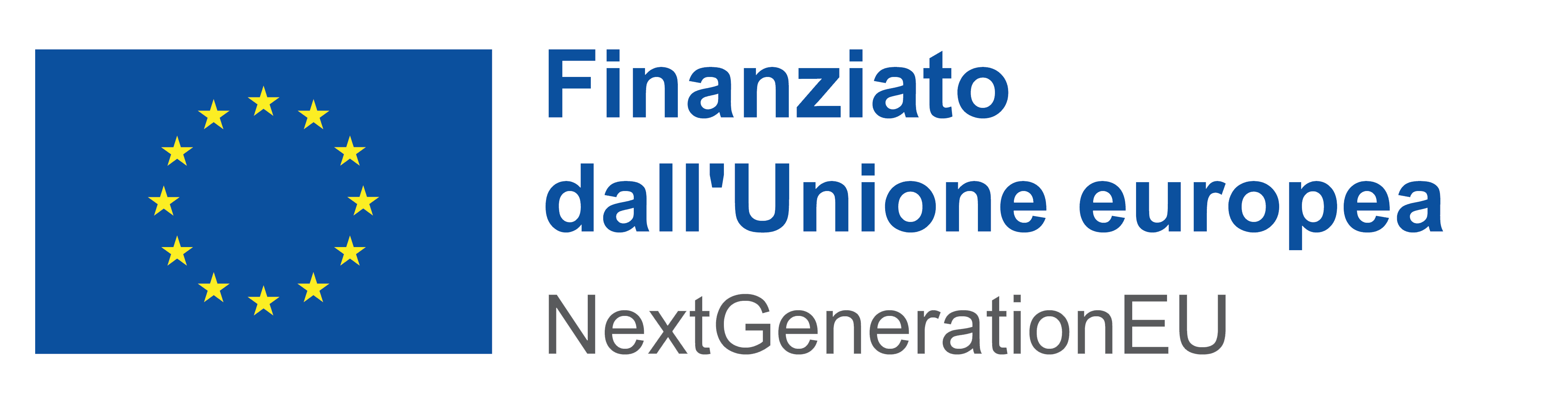Concerto disponibile su RaiPlay.it
Zubin Mehta - Concerto di Pasqua
Programma
Il concerto sarà trasmesso da Rai Cultura su Rai 1, il 2 aprile, dopo la celebrazione della Via Crucis (ore 00.45 circa) e in replica sabato 3 aprile su Rai 5 (alle ore 8.35 e alle ore 19.35).
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia in sol minore K. 550
Messa dell'incoronazione in do maggiore per soli, coro e orchestra K. 317
Ave verum corpus, mottetto in re maggiore K. 618 per coro, archi e organo
Nell’ambito del progetto “Omaggio all’Umbria”, con il patrocinio di: Comune di Orvieto, Camera di Commercio dell’Umbria, l’Università per Stranieri di Perugia e Unicef Italia.
Sponsor del concerto: il Ministero della Cultura, la Regione Umbria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Banca Intesa Sanpaolo e la Fae Terni SPA.
-
Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550
Il 1788 è l’anno che segna l’addio di Mozart al genere sinfonico con le ultime tre Sinfonie - K. 543, K. 550, K. 551 - realizzate in soli tre mesi e forse pensate come unico grande affresco sonoro. Nell’estate di quell’anno Mozart vive un periodo molto tormentato. Dopo lo scarso successo del Don Giovanni a Vienna, il compositore è angosciato dai debiti e provato dalle ristrettezze economiche e spera quindi di risollevarsi con quelle tre sinfonie composte di getto in uno straordinario impeto creativo. Tra la serenità che pervade la Sinfonia K. 543 e la grandiosità solenne della K. 551 Jupiter, la Sinfonia in sol minore K. 550 si distingue per il carattere “notturno” e dolente. I quattro movimenti della sinfonia (Molto Allegro - Andante - Minuetto - Allegro assai) accolgono al loro interno un nuovo sentimento di inquietudine profonda che serpeggia in orchestra dall’inizio alla fine. Se il primo movimento, privato della canonica introduzione lenta, spicca per l’attacco immediato affidato agli archi - tra i più suggestivi mai scritti - l’Andante che segue assume toni nobili ed elegiaci. Il Minuetto alterna severità barocca e movenze galanti, mentre l’Allegro assai (che ispirò anche lo Scherzo della Quinta Sinfonia di Beethoven) chiude l’opera con un moto rapido e inesorabile di forte impatto drammatico.
Messa dell'incoronazione in do maggiore per soli, coro e orchestra K. 317
Nel settembre del 1777 Mozart lasciò Salisburgo e si mise in viaggio con la speranza di trovare un nuovo incarico lavorativo presso un’altra corte dove poter esprimere al meglio il proprio talento. Salisburgo gli stava stretta, il rapporto con l’Arcivescovo Colloredo pure, così il compositore partì alla volta di Monaco, Augusta, Mannheim e Parigi, senza però riuscire a ottenere l’incarico sperato. Dopo il lungo peregrinare, nel gennaio del 1779 ritornò a malincuore a Salisburgo per riprendere servizio alla corte arcivescovile. Colloredo lo aveva riassunto come organista di corte, un incarico che prevedeva la realizzazione di nuove composizioni sia per la Chiesa che per la corte. Proprio in quel periodo, che sarà l’ultimo trascorso da Mozart nella sua città natale, vedono la luce numerose composizioni sacre tra cui la Messa in do maggiore per soli, coro e orchestra K. 317 detta ‘Messa dell’Incoronazione’. Secondo la tradizione, la Messa K. 317 era destinata alla festa annuale per l’incoronazione della sacra immagine della Vergine Maria conservata nel santuario di Maria Plain nei pressi di Salisburgo (evento celebrato ogni anno il 27 giugno). Ma considerando la data di fine composizione della ‘Messa dell’Incoronazione’ - il 23 marzo 1779 - pare più probabile che Mozart l’avesse scritta per le funzioni liturgiche del periodo pasquale. Per volere dell’Arcivescovo, che poco amava la prolissità barocca e l’ardita scrittura contrappuntistica tipica della musica sacra del tempo, le messe cantate a Salisburgo dovevano rispettare il principio di brevità ed evitare ogni orpello superfluo. La Messa K. 317, pur sfoggiando un imponente organico orchestrale tipico delle grandi occasioni, appartiene infatti al genere della missa brevis con le canoniche sei sezioni dell’ordinarium missae: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Così Mozart non deluse le aspettative e compose una Messa con temi cantabili e di facile ascolto, adottando nelle parti corali una scrittura prevalentemente omofonica ma anche disseminando qua e là alcuni passi solistici di particolare intensità, basti pensare al solo del soprano nel Kyrie o nell’Agnus Dei, la cui melodia ricorda, anticipandola, l’aria della Contessa “Dove sono i bei momenti” nelle Nozze di Figaro.
Ave verum corpus K. 618
Il breve mottetto per coro, archi e organo Ave verum corpus KV 618 è tra i brani più conosciuti e amati della produzione sacra mozartiana. Nell’estate del 1791 Mozart aveva raggiunto la moglie in villeggiatura a Baden e per sdebitarsi con l’amico Anton Stoll, direttore del coro locale, compose questa pagina che venne eseguita durante le celebrazioni della festa del Corpus Domini. Nell’Ave verum Mozart adotta una scrittura omofonica per meglio sottolineare il significato del testo, realizzando pur nella brevità - solo quarantasei battute - e con pochi mezzi strumentali - l’organico è ridotto ai soli archi e organo vista la destinazione per la chiesa di paese - un gioiello di immediatezza espressiva.
Artisti
Direttore
Zubin Mehta
Soprano
Eva Mei
Mezzosoprano
Francesca Cucuzza
Tenore
Valentino Buzza
Basso
Emanuele Cordaro
Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro del Coro
Lorenzo Fratini
Zubin Mehta
Soprano
Eva Mei
Mezzosoprano
Francesca Cucuzza
Tenore
Valentino Buzza
Basso
Emanuele Cordaro
Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro del Coro
Lorenzo Fratini
Recite
Duomo di Orvieto - RaiPlay
Locandina